SCUOLA: GLI ARGOMENTI DI DISCUSSIONE ESTIVI
Come ogni estate il dibattito sulla scuola è acceso. Negli anni i social l’hanno amplificato ma a ben vedere gli argomenti di discussione sono rimasti identici.
Ormai la frequentazione dei social mi incoraggia sempre meno ad aggiornare questo blog: molto più comodo e veloce esprimere il mio parere attraverso Twitter. A volte le discussioni sono molto animate ma gli argomenti “estivi” non cambiano. Vediamo quali sono, escludendo le “vacanze dei prof” su cui sorvolo volentieri perché ogni tentativo di chiarire che le “vacanze” degli studenti non coincidono con le “ferie” degli insegnanti è sempre stato fallimentare. Tuttavia, se vi fa piacere, vi invito alla lettura di questo post in cui mi soffermo sul significato delle due parole “ferie” e “vacanze”.
1) I compiti delle vacanze

Due sono gli orientamenti:
- I compiti vanno assegnati perché le vacanze estive si prolungano per tre mesi e i bambini/ragazzi hanno bisogno di tenersi in allenamento
- Niente compiti perché le vacanze sono vacanze, appunto, lasciamo che i bambini/ragazzi se ne stiano in pace.
C’è anche un terzo orientamento, quello dei maestri o dei prof sognatori e poetici. Loro non assegnano compiti ma attività gratificanti, perlopiù ludiche, da svolgere preferibilmente con la famiglia. Si spazia dalle passeggiate nei campi per avvicinarsi alla natura, alla contemplazione del tramonto in riva al mare, per finire con la compilazione di un diario in cui annotare queste magnifiche ed estasianti esperienze.
Tralasciando i consigli poetici, invito alla lettura di questo post del 2014.
2) Le vacanze estive troppo lunghe

Strettamente legato al precedente, anche l’argomento “vacanze estive” è motivo di discussione accesa ogni estate. Anche in questo caso gli orientamenti sono due:
- Non è giusto che i docenti abbiano tre mesi di vacanza pagati
- Gli studenti fanno troppe vacanze e le famiglie non sanno cosa fare dei figli durante il lungo periodo
Sul primo punto taccio, come ho già scritto nella parte introduttiva.
Quanto al secondo punto, la protesta delle famiglie è oggetto di disapprovazione in quanto chi vive la scuola ogni giorno sa bene che le 14 settimane di vacanza degli studenti non equivalgono a un minor numero di giorni di lezione rispetto agli altri Paesi della UE. Varia la distribuzione delle settimane di vacanza ma in Italia i giorni di lezione obbligatori sono 200, il numero più alto nell’ambito dei Paesi europei.
Ne ho parlato qui e, sebbene siano passati 9 anni (l’articolo è del 2014), le cose non sono cambiate molto. Anche le polemiche sono sempre quelle.
3) I debiti formativi (ossia quelli che ancora qualcuno ostinatamente continua a denominare “esami di riparazione” o “esami per i rimandati a settembre”)

Parliamo ovviamente delle scuole superiori (secondarie di secondo grado, secondo la dicitura corretta) dove gli esami non esistono da un bel po’; chi non raggiunge la sufficienza in una o più materie a giugno ha il giudizio sospeso e deve recuperare le insufficienze. Si chiamano debiti formativi e il loro superamento è regolamentato autonomamente da ciascun istituto nei tempi e nelle modalità. Nella maggior parte dei casi ormai da qualche anno si tende a organizzare i recuperi nell’ultima settimana di agosto. In qualche caso il recupero avviene a luglio, in altri le prove di accertamento slittano ai primi di settembre. Le cose vanno così da quando l’allora ministro Fioroni firmò il DM 80/2007 e nulla è stato modificato negli anni a seguire.
Quest’estate il dibattito è stato infiammato dalla presunta volontà del ministro del MIM, Giuseppe Valditara, di cambiare le carte in tavola e intimare lo svolgimento delle prove di recupero dei debiti dal 16 agosto in poi ed entro la fine del mese. Una “decisione” che avrebbe messo in discussione le ferie dei docenti, specialmente quelli impegnati negli esami che difficilmente avrebbero potuto godere dei 32 giorni di ferie (più 4 per le festività soppresse) cui hanno diritto. Tuttavia, leggendo bene la circolare del ministro, si capisce che la normativa era rimasta quella di sempre e che volendo gli “esami” si sarebbero potuti svolgere anche all’inizio di settembre, purché entro il giorno d’inizio delle lezioni, che varia da regione a regione e financo da scuola a scuola, grazie all’autonomia.
Niente di nuovo sotto il sole di luglio, insomma. Basta leggere qui (post pubblicato nel 2011).
4) L’onere per le famiglie delle lezioni private

Anche questo argomento è strettamente legato al punto precedente. Nonostante le scuole offrano la possibilità di frequentare corsi di recupero, le famiglie sono perlopiù orientate verso le lezioni private. Da un’indagine promossa dall’“Osservatorio ripetizioni private” di Ripetizioni.it è emerso che circa un quarto degli alunni di scuole medie e superiori si rivolge agli insegnanti privati, non specificatamente d’estate ma durante tutto l’anno (anche per scongiurare i debiti…).
Il problema connesso a questa abitudine riguarda anche gli stessi insegnanti. Il business delle ripetizioni è, infatti, molto lucroso. Chi ha tempo e voglia può effettivamente ricavarne un bel guadagno, prevalentemente in nero, arrotondando così lo stipendio che, diciamolo, è tra i più bassi d’Europa e non rende merito agli studi universitari, master e specializzazioni richiesti per ricoprire questo ruolo.
Questo mercato con un po’ di buona volontà è facilmente evitabile. Lo spiego qui (articolo del 2016).
5) La bocciatura

Affrontare una bocciatura non è mai semplice, e ciò vale sia per gli studenti sia per le famiglie. Negli ultimi anni, però, si è assistito a un aumento di ricorsi al Tar da parte di genitori e studenti incapaci di comprendere che la bocciatura non è mai facile nemmeno per i docenti i quali devono prendere questa decisione la quale, nella maggior parte dei casi, si basa su valide motivazioni, prima tra tutte la non adeguata preparazione dello studente alla frequenza con profitto della classe successiva. Non a caso, in termini tecnici, la “bocciatura” è chiamata “non ammissione alla classe successiva”.
All’inizio di luglio ha tenuto banco, nelle discussioni sui social, il caso di una studentessa di Trento la quale, nonostante le 5 insufficienze, ha fatto ricorso al Tar perché non ammessa all’esame di Stato (o “maturità” come si tende a dire ancor oggi). Riammessa dal tribunale amministrativo, la ragazza ha affrontato senza successo le prove suppletive ed è stata bocciata dopo l’orale.
Anche in passato si sono verificati dei clamorosi insuccessi nell’ambito dei ricorsi al Tar. Per esempio, una sentenza del 2014 non solo dava ragione ai docenti ma costituiva una sorta di schiaffo morale ai genitori i quali, secondo i giudici, avevano manifestato stupore di fronte al giudizio conclusivo emesso nei confronti del loro figliuolo e avevano mancato nel dovere di vigilare costantemente sul loro comportamento e andamento scolastico, al fine di apprestare, in caso di necessità, tempestivi e idonei interventi correttivi o di sostegno.
Ai genitori delusi dalla bocciatura del figlio o della figlia consiglio la lettura di questo post datato giugno 2018.
6) Il voto di condotta

Negli ultimi anni la stampa ha messo in evidenza degli episodi di bullismo verso i compagni e/o aggressione nei confronti degli insegnanti da parte di allievi particolarmente discoli (per usare un eufemismo). Sotto accusa, nella maggior parte dei casi, la scarsa educazione ricevuta in famiglia ma, secondo me, in situazioni come quelle citate giocano un ruolo importante anche il contesto e i modelli che i ragazzi e le ragazze seguono. Il fatto, poi, che attraverso i social episodi così gravi siano diffusi senza scrupoli da giovani e giovanissimi a caccia di like, ha certamente amplificato il problema.
Due sono stati, durante questi mesi, gli episodi messi in risalto dalla stampa e inevitabilmente rimbalzati sui social.
Il primo riguarda il sedicenne che ha ferito in modo grave la sua insegnante di italiano al liceo scientifico Alessandrini di Abbiategrasso ed è stato espulso e bocciato con il 5 in condotta, anche in presenza di buone valutazioni nel profitto. I genitori hanno preannunciato il ricorso al Tar ma finora non è stato reso pubblico alcunché a riguardo. Sta di fatto che con il 5 in condotta è prevista la bocciatura, anche se la media dei voti è buona (DM 5/2009).
Il secondo caso ha visto come protagonisti dei ragazzini che, in una scuola di Rovigo, a ottobre hanno sparato alla loro insegnante con una pistola a pallini e, nonostante ciò, sono stati promossi con il 9 in condotta. L’azione era stata ripresa con un telefonino e postata sui social. Ciò ha indignato il ministro Valditara che ha fatto riconvocare il Consiglio di Classe; in questa nuova riunione i 9 sono stati abbassati, con buona pace di tutti. In realtà, a mio parere, questa azione di forza ha creato un pericoloso precedente.
Al di là di questi singoli episodi, a mio parere la questione del voto di condotta deve essere riaffrontata. Da parte sua Valditara ha preannunciato che chi avrà 6 nel comportamento dovrà recuperare “a settembre” (vedi punto 3) in Educazione Civica. Peccato che questa non sia una materia a se stante (le 33 ore obbligatorie sono distribuite su più insegnamenti e riguardano molti ambiti) e che il 6 costituisca di fatto il voto minimo per la sufficienza. I cosiddetti debiti si danno con voti inferiori al 6, ne consegue che la proposta del ministro sia irricevibile e possa dar adito a numerosi ricorsi al Tar. A meno che non si voglia condonare qualche 5, a seconda della gravità dei fatti e del momento in cui sono accaduti (se nel primo o nel secondo periodo dell’as.), e riconvertirlo in “debito” al posto della bocciatura. La questione mi sembra molto controversa.
La mia riflessione, però, vuole prendere in esame la valutazione della condotta nella scala decimale, al pari delle materie di insegnamento. Abbiamo detto che il 5 corrisponde all’insufficienza e il 6 è il voto minimo per la sufficienza, come è sempre stato. Il voto di condotta fa media come gli altri e dovrebbe avere, quindi, un valore simile agli altri voti presenti in pagella. Ma se da un lato le valutazioni nella diverse discipline raramente arrivano al 10, perché invece i 10 in condotta fioccano come neve a gennaio? E perché si guarda con sospetto chi merita 8 nel comportamento? Un 8 in Latino o Matematica è forse un brutto voto?
Insomma, la discussione è piuttosto lunga quindi invito alla lettura di questo post pubblicato nel 2020.
7) I risultati dei test Invalsi

Non poteva mancare, come argomento del dibattito estivo, quello sui test Invalsi. L’istituto, infatti, dopo la fine delle lezioni ogni anno pubblica i primi risultati facendo una panoramica generale, cui seguirà nei mesi prossimi il feedback destinato alle scuole. I titoli dei quotidiani sono stati più o meno simili: «In italiano e matematica insufficiente uno studente su due». Ciò ha scatenato la protesta degli insegnanti poiché, leggendo il rapporto ufficiale sul sito dell’istituto, risulta chiaro che le cose stanno messe un po’ diversamente rispetto a quanto fatto credere dalla stampa.
Non voglio tediare nessuno entrando nei dettagli, ma invito a leggere questo post scritto nel 2012 in cui mi chiedevo a cosa servano i test se nessuno li sa leggere per poterne trarre un qualche beneficio a favore di studenti e docenti. Me lo chiedo ancora.
8) La presunta demotivazione dei docenti perché pagati poco

Anche questo è per certi aspetti un argomento legato al precedente. Secondo la vox populi i docenti italiani temono i test Invalsi perché gli scarsi risultati sarebbero un chiaro segnale della loro impreparazione e/o della scarsa motivazione dovuta all’esiguo stipendio percepito.
In primo luogo chiarisco che i test non hanno lo scopo di valutare l’abilità dei docenti bensì rilevano la qualità dell’apprendimento. Voi direte: vabbè, se hanno insegnanti scarsi avranno anche risultati scarsi. Ragionamento opinabile perché nella dinamica insegnamento-apprendimento vengono messi in campo fattori di rilevante importanza come per esempio: il numero degli studenti per classe, la presenza di L 104 e/o DSA, la presenza di studenti non italofoni o che comunque non conoscono bene la lingua, il bacino d’utenza in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie... il discorso è troppo ampio per essere sintetizzato.
In secondo luogo, si deve tener conto del fatto che spesso gli studenti, sapendo che il risultato dei test non ha alcuna rilevanza sul profitto, li eseguono svogliatamente e in fretta, senza prestare la dovuta attenzione alle domande e a volte, convinti di aver capito quanto richiesto, sbagliano semplicemente perché non hanno letto bene le consegne, non perché non sanno leggere o comprendere ciò che leggono. Mi riferisco in particolare alle prove di Italiano ma anche per svolgere bene i test di matematica bisogna prestare attenzione alle richieste.
Quanto allo stipendio degli insegnanti, è chiaro a tutti che è molto modesto e non restituisce dignità non solo agli insegnanti che si impegnano ma anche al titolo di studio richiesto – da anni la laurea è un requisito anche nella scuola primaria – per insegnare. Tutti i ministri che si sono avvicendati in viale Trastevere hanno preso atto che chi insegna guadagna poco, anche in considerazione dei numerosi oneri che questa professione impone. Tutti hanno dichiarato che gli stipendi dovrebbero essere allineati a quelli dei colleghi europei (a me viene da ridere pensando che in Germania, per fare un esempio, i docenti guadagnano più del doppio di noi) ma nessuno ha fatto molto. Contratti scaduti e rinnovati dopo molti anni, arretrati forfettari che non tengono conto realmente dell’importo dovuto, aumenti irrisori. Però gli insegnanti, pur malpagati, non si tirano indietro e fanno il loro dovere, almeno la maggioranza, con dedizione e piena consapevolezza della responsabilità che grava su di loro: l’istruzione e la formazione delle generazioni future.
Altre, non lo stipendio, sono le cause che possono portare se non alla demotivazione quantomeno a un certo scoraggiamento. Lo spiegavo qui all’allora ministra Giannini. Correva l’anno 2014 ma i problemi evidenziati allora sono, a mio parere, rimasti immutati.
Concludo questa carrellata scusandomi per i numerosi link. Spero di aver sollecitato la vostra curiosità spingendovi alla lettura se non di tutti i post almeno di quelli che ritenete più interessanti.
Buona estate a tutti!
[le immagini provengono da questo blog o da marisamoles.wordpress.com. Nel caso provengano da siti non linkati o siano coperte da copyright, prego contattarmi per e-mail]
Pubblicato il 5 agosto 2023, in calendario scolastico, compiti per le vacanze, Debiti Formativi, docenti, Esame di Stato, famiglia, Ministero Istruzione, scuola, studenti, Test Invalsi, Valutazione studenti, web con tag compiti delle vacanze, docenti, famiglia, Giuseppe Valditara, scuola, studenti, Test InValsi, vacanze, valutazione studenti, web. Aggiungi il permalink ai segnalibri. 3 commenti.



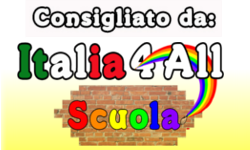


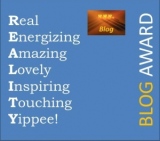




Bell’articolo. Si tratta di polemiche stantie che non tengono conto della tipicità italiana dove fare lezione già a giugno risulta difficile. Lavoriamo in edifici spesso concepiti come fabbriche, gelidi in inverno e forni d’estate. Sulla questione ripetizioni sarebbe interessante la proposta di regolamentazione all’interno della scuola, ma la normativa prevede l’impossibilità di farle a studenti del proprio istituto. D’altra parte la coperta è corta e con le 8-10 ore previste (sempre che parte il
Corso) non si può fare molto. Sulle ferie dei prof. …solo chi vive con un docente sa che non sono periodi vuoti né che risultano immeritate
"Mi piace"Piace a 1 persona
Nell’articolo però specifico che non si possono dare lezioni private agli allievi della propria scuola. L’attività “intramoenia” permetterebbe ai docenti di quella scuola di seguire allievi di altre scuole. Per esempio, se in una città ci sono più licei scientifici, se insegno in quello X posso dare lezioni agli allievi dell’ Y, oppure posso dare ripetizioni di latino anche agli allievi delle ex magistrali. Stessa cosa per le altre discipline. Sarebbe più difficile nelle piccole città, me ne rendo conto, ma laddove è possibile, perché non tentare? Anche avere a disposizione spazi adeguati, con pc, smartboard e altro sarebbe sempre meglio che fare lezione nelle case dove non sempre ci sono gli spazi e la tranquillità (immagino un docente con famiglia numerosa…). Creare un albo di docenti disponibili per le lezioni private sarebbe sicuramente un vantaggio (le famiglie non devono andare a caccia degli insegnanti) e anche una garanzia.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Sì, anche se dubito che le segreterie, oberate di lavoro, sarebbero disponibili a farle.
"Mi piace"Piace a 1 persona